Il metodo scientifico è un pilastro fondamentale di tutte le scienze, ma come funziona esattamente? In questo articolo, scopriamo insieme quando è nato, quali sono le sue fasi principali e perché ancora oggi è essenziale per comprendere il mondo che ci circonda.
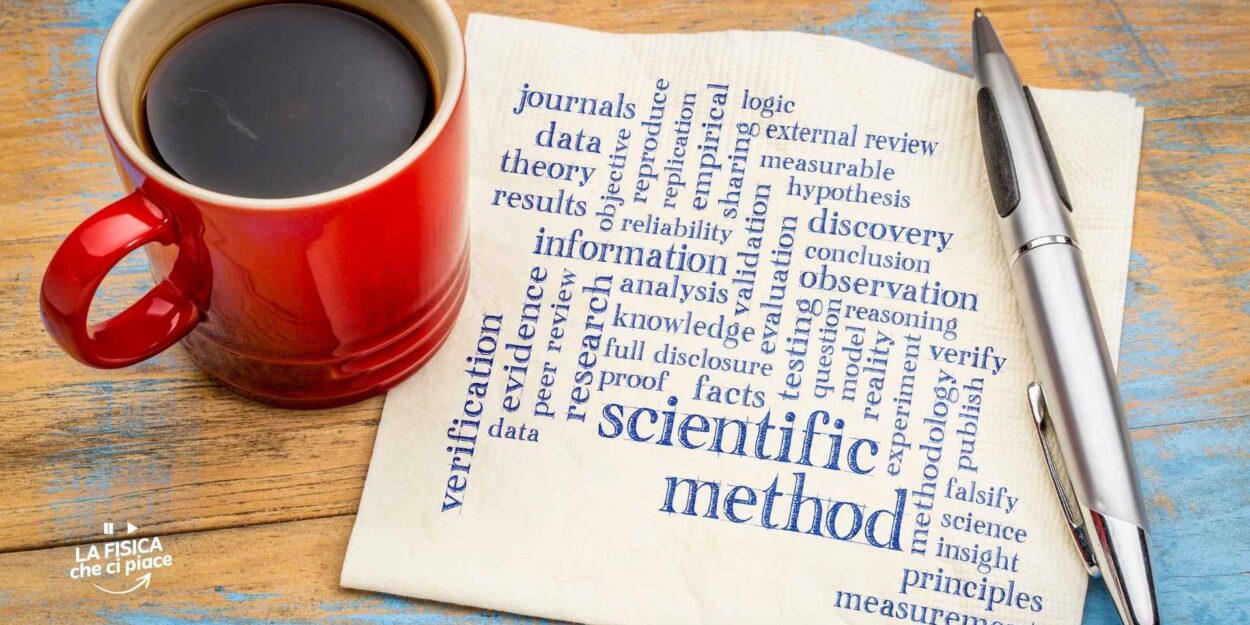
Le origini del metodo scientifico
Sebbene il metodo scientifico venga spesso associato esclusivamente alla figura di Galileo Galilei o ad altri grandi scienziati dell’età moderna, le sue origini storiche risalgono al mondo antico.
Le sue prime tracce, infatti, si trovano nel pensiero filosofico dell’Antica Grecia, dove per la prima volta i filosofi iniziarono a credere che la natura potesse essere compresa attraverso il pensiero razionale e non solo attraverso il mito o la religione.
Già Socrate, ad esempio, alle origini della filosofia, proponeva un metodo basato sul dialogo: attraverso la discussione e il confronto critico era possibile risalire a concetti universali come la giustizia o la bellezza, ponendo le basi di un ragionamento strutturato.
Nel campo della scienza antica, invece, Pitagora e i pitagorici furono tra i primi a sostenere che l’Universo possedesse una struttura matematica, proponendo un approccio aritmetico e geometrico per descrivere i fenomeni naturali.
Tuttavia, i primi elementi formali del metodo matematico vennero descritti da Aristotele negli Analitici e sistematizzati da Euclide nei suoi Elementi, sicuramente una delle opere più influenti nella storia del pensiero scientifico. Questo metodo era sostanzialmente articolato in due fasi: venivano stabilite delle premesse (assiomi o postulati) e poi dedotte delle conseguenze logiche da esse.
Nonostante sia impossibile tracciare un vero e proprio spartiacque nel lungo percorso del progresso scientifico, è con l’inizio dell’età moderna che il dibattito sul metodo iniziò ad assumere un significato più profondo, grazie soprattutto al contributo di figure come Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei e Isaac Newton, che non solo gettarono le basi della scienza moderna, ma svilupparono anche riflessioni sul modo in cui la conoscenza scientifica dovrebbe essere costruita.
Il contributo di Galileo Galilei al metodo scientifico
Galileo Galilei, da molti considerato il padre della scienza moderna, ha avuto senza dubbio un ruolo fondamentale nello sviluppo del metodo scientifico moderno.
È stato un vero e proprio rivoluzionario: ha avuto il coraggio di mettere in discussione le verità accettate del suo tempo ed è stato il primo ad introdurre formalmente il metodo sperimentale, su cui si fonda l’attuale ricerca scientifica. Secondo questo metodo, un’affermazione scientifica può essere considerata valida soltanto se è verificata attraverso esperimenti e non perché basata su qualche autorità, come avveniva in passato con frasi del tipo “lo ha detto Aristotele”.
Con Galileo nasce quindi una nuova visione della scienza, fondata su un principio tanto semplice quanto rivoluzionario: non importa chi lo dice, ma come lo dimostra. Non è più sufficiente osservare i fenomeni o affidarsi alle credenze del passato: per costruire una conoscenza scientifica solida, è necessario riprodurre i fenomeni in condizioni controllate, raccogliere dati misurabili e analizzarli con strumenti matematici, così da formulare leggi universali.
Come egli stesso scriveva ne Il Saggiatore, la natura è un libro scritto in linguaggio matematico, e per comprenderlo dobbiamo osservare il mondo sperimentalmente, usando gli strumenti che essa stessa mette a disposizione.

Come funziona il metodo scientifico: le fasi principali
Il metodo scientifico è un procedimento rigoroso e strutturato, utilizzato per indagare i fenomeni naturali, che si basa sull’osservazione, sulla sperimentazione, sulla misura e sulla verifica dei risultati.
L’approccio adottato da Galileo può essere articolato in quattro fasi fondamentali:
Osservazione del fenomeno
Tutto inizia con le cosiddette “sensate esperienze”, ovvero l’osservazione diretta e misurabile di un fenomeno naturale. In questa fase lo scienziato raccoglie dati, misura le variabili in gioco e cerca eventuali regolarità da interpretare.
Formulazione dell’ipotesi
Sulla base delle osservazioni effettuate si formula un’ipotesi scientifica: una spiegazione provvisoria del fenomeno, che deve essere verificabile e falsificabile.
Deduzione matematica
L’ipotesi viene sviluppata matematicamente, trasformandola in previsioni quantitative. È qui che entrano in gioco gli strumenti della matematica, fondamentali per dedurre le conseguenze logiche dell’ipotesi e collegare le variabili in gioco.
Verifica sperimentale
La fase finale consiste nella verifica sperimentale: l’esperimento viene riprodotto per testare i risultati previsti. Se i risultati confermano l’ipotesi, si può formulare una legge scientifica; se la smentiscono, l’ipotesi deve essere modificata o scartata.
In questo processo è possibile individuare due momenti chiave: una fase induttiva, che parte dall’osservazione del particolare per formulare un’ipotesi più generale, e una fase deduttiva, in cui l’ipotesi viene testata per giungere a una legge valida in contesti più ampi. È proprio questo passaggio, dal particolare al generale e viceversa, a rendere il metodo scientifico uno strumento tanto potente quanto affidabile.
Perché il metodo scientifico è fondamentale per la scienza e la società
Il metodo scientifico non è una semplice procedura da applicare o un banale “ricetta” da seguire per fare esperimenti: è il linguaggio universale della scienza, che consente alla comunità scientifica internazionale di comunicare, confrontarsi e costruire conoscenza condivisa. Infatti, è proprio grazie a questo approccio rigoroso che possiamo distinguere ciò che è scienza da ciò che scienza non è: un’affermazione scientifica deve poter essere sempre verificata, misurata e, se necessario, anche falsificata.
E in un mondo come il nostro, in cui convivono teorie attendibili, opinioni personali e pseudoscienze, il metodo scientifico rappresenta una vera palestra di pensiero critico che aiuta a porci domande consapevoli e a riconoscere informazioni affidabili.
Sapevate che…
Galileo ha davvero lanciato oggetti dalla Torre di Pisa?
Contrariamente a ciò che viene solitamente raccontato, non ci sono prove storiche certe che Galileo abbia davvero condotto esperimenti dei gravi dalla Torre di Pisa. Molti storici mettono in dubbio che l’episodio sia realmente accaduto, anche perché un esperimento di questo tipo, a causa dell’attrito dell’aria, avrebbe portato a risultati contrari a quelli sostenuti da Galileo.
Perché le teorie scientifiche sono sempre provvisorie?
Uno degli aspetti più affascinanti del metodo scientifico è che le teorie non sono mai considerate assolute. Anche le teorie più solide sono sempre aperte alla revisione: la scienza, infatti, è un processo in continua evoluzione e ciò che è vero oggi potrebbe essere messo in discussione domani con nuove scoperte.
a cura di Giada Cacciapaglia