Che fastidio il fischio prodotto dal gessetto sulla lavagna, ma se lo spezzi non lo fa più: ecco perché
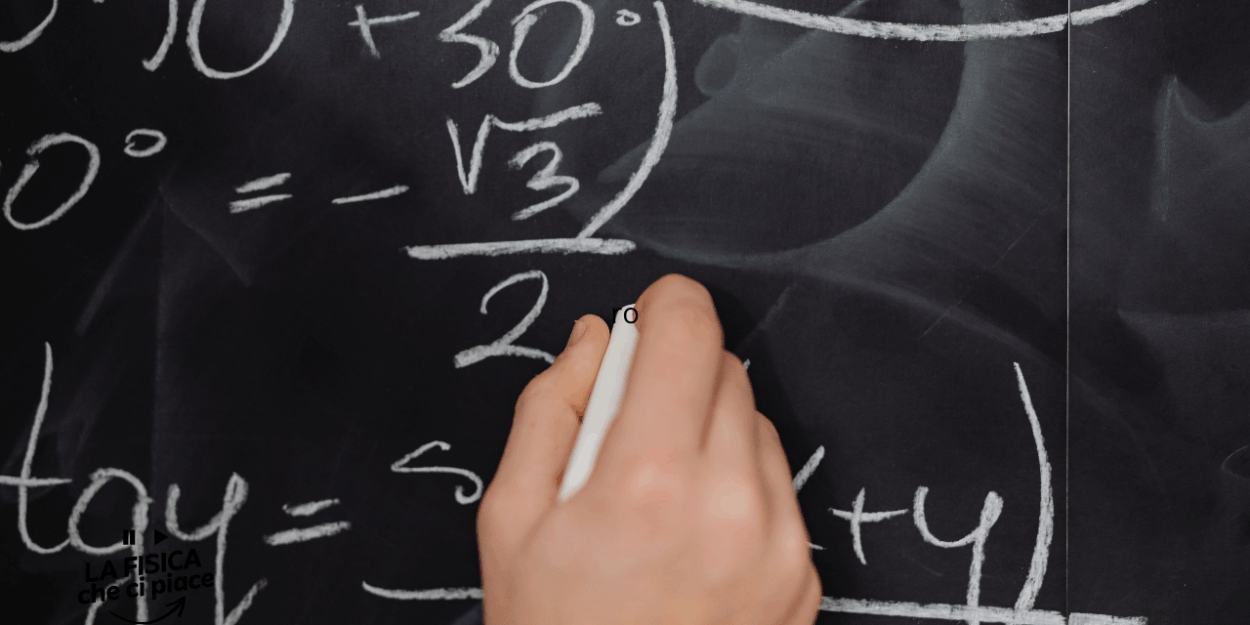
Può essere davvero fastidioso, quasi insopportabile per altre persone. Ma basta un piccolo gesto per risolvere il problema.
Il gessetto, nella sua semplicità, è uno degli strumenti più iconici del mondo dell’insegnamento. Un piccolo cilindro di carbonato di calcio che, a contatto con la lavagna, lascia un segno bianco immediato e visibile, pronto a essere cancellato con un gesto. Nonostante la tecnologia abbia portato tablet e schermi interattivi nelle aule, il gessetto continua a evocare l’immagine classica della conoscenza trasmessa passo dopo passo.
Ogni linea tracciata racconta un’idea che prende forma. È un modo fisico e diretto di pensare: il pensiero si traduce in segno, e il segno diventa spiegazione. L’insegnante costruisce il discorso un tratto alla volta, mentre gli studenti seguono il ritmo della scrittura, quasi come se potessero vedere il ragionamento nascere davanti ai loro occhi.
Il gessetto ha anche un valore simbolico. Rappresenta la transitorietà del sapere: ciò che si scrive può essere cancellato, modificato, corretto. È un invito costante a ripensare, a riscrivere, a migliorare. Niente è mai definitivo, tutto può essere riformulato.
E poi c’è la sua dimensione artigianale. Ogni tratto è leggermente diverso, ogni pressione lascia un’impronta unica. Forse è proprio questa imperfezione a renderlo così umano: il gessetto non solo insegna, ma ricorda che imparare è un processo fatto di tentativi, cancellature e nuove scoperte.
Quando anche un gessetto racconta la fisica
A volte, i fenomeni più curiosi nascono dalle cose più semplici. Prendiamo un gessetto, per esempio: quello stesso strumento che da decenni accompagna insegnanti e studenti nelle aule di tutto il mondo. Basta passarlo sulla lavagna e, oltre al segno bianco, ecco arrivare quel suono sottile, quasi fastidioso, che tutti conoscono. Ma se il gessetto si rompe, accade qualcosa di strano: il rumore sparisce. La mano continua a scrivere, la lavagna resta la stessa, eppure il suono non si sente più. Una piccola differenza, certo, ma dietro di essa si nasconde un frammento affascinante di fisica.
Quel sibilo così riconoscibile non è altro che un suono, e come ogni suono possiede una frequenza. È la vibrazione che si propaga nell’aria e che l’orecchio umano può percepire solo entro un certo intervallo: tra i 16 e i 20.000 hertz, più o meno. Tutto ciò che sta oltre questo limite resta fuori dalla nostra portata, come un linguaggio nascosto che il mondo continua a parlare anche quando noi non lo sentiamo più.
La lunghezza che decide il suono
Quando il gessetto è intero, la sua lunghezza determina la frequenza delle vibrazioni che produce. In pratica, più lungo è il pezzo di gesso, più bassa sarà la frequenza del suono emesso e quindi più udibile. È proprio questo che genera quel tipico stridio, la nota acuta che risuona ogni volta che la superficie del gessetto sfrega contro la lavagna. La frequenza, infatti, è inversamente proporzionale alla lunghezza dell’oggetto che vibra: più corto è, più il suono diventa rapido e sottile.
Quando il gessetto si spezza, la sua lunghezza diminuisce e la frequenza delle vibrazioni aumenta oltre la soglia che l’orecchio umano riesce a percepire. In altre parole, il gesso continua a “parlare”, ma in un linguaggio che non possiamo più ascoltare. Il suono esiste ancora, solo che si è trasformato in un’onda troppo veloce per noi, un ultrasuono.
