La teoria delle stringhe è una delle ipotesi più studiate di quello che potrebbe essere il comportamento più intimo dell’universo. Proviamo ad indicarne qualche idea
Un universo di corde vibranti: la teoria delle stringhe
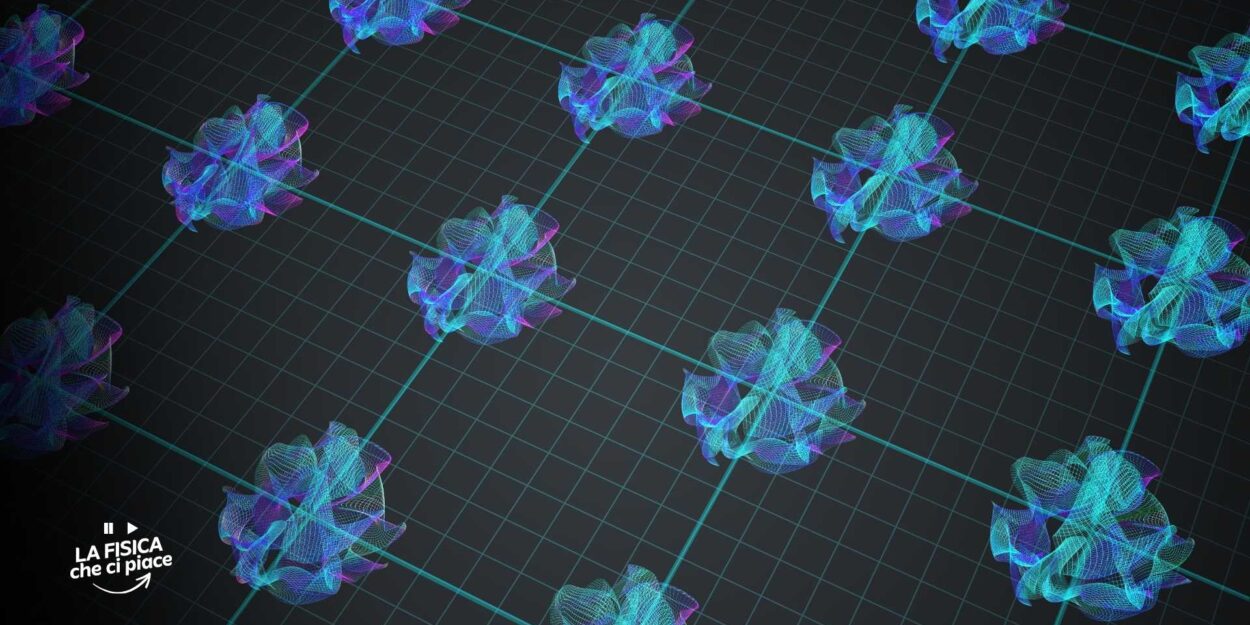
Origini della teoria delle stringhe e significato del termine
La teoria delle stringhe nasce come tentativo di unificare le due grandi descrizioni della natura: la relatività generale, che governa la gravità e le strutture cosmiche, e la meccanica quantistica, che descrive le strutture atomiche e subatomiche. Le due teorie, pur straordinariamente efficaci nei rispettivi ambiti, risultano incompatibili quando si cerca di farle andare insieme, benché ci siano dei successi nello studio dei buchi neri o nell’origine dell’universo. A partire da Schrödinger e Dirac si era tentato di far coesistere la relatività ristretta (che prevede uno spazio-tempo piatto) con la meccanica quantistica all’interno della teoria quantitativa dei campi, teoria portata in seguito da Feynman ed altri a grandi successi. Nonostante tutto la frattura concettuale tra relatività generale e meccanica quantistica permaneva, e negli anni ’70 si sviluppò l’idea che si poteva trattare le particelle fondamentali modellandole come “corde” unidimensionali, idea che in qualche modo ricordava la brillante trattazione che Dirac fece dell’elettrone. La parola “stringa” deriva proprio da questa immagine: degli oggetti unidimensionali che, a seconda della modalità di oscillazione, si manifestano come particelle diverse, analogamente a come una corda di violino produce note differenti in base alla vibrazione.
Ma i fisici hanno cercato ancora più a fondo, ed oltre ad aver ipotizzato la teoria delle stringhe, hanno ideato anche le teoria delle superstringhe, che cerca di unire le stringhe con l’ipotesi che in natura ci siano particolari e fondamentali simmetrie che caratterizzerebbero tutte le particelle. Ma questa è un’altra storia.
Matematica della teoria delle stringhe: strumenti e limiti
La formulazione matematica della teoria delle stringhe utilizza strumenti avanzati come la teoria quantistica dei campi, la geometria differenziale, la topologia e l’algebra non commutativa. Un ruolo interessante è svolto dalle cosiddette varietà di Calabi–Yau, spazi geometrici complessi a più dimensioni che permettono di gestire, più tecnicamente “compattificare”, le dimensioni extra previste dalla teoria. Inoltre, la teoria fa uso di concetti come le simmetrie di gauge e le trasformazioni conformi, indispensabili per descrivere aspetti (e variazioni) della teoria in modo coerente. Tuttavia la matematica attuale non è ancora sufficiente a risolvere tutti i problemi: mancano strumenti pienamente consolidati per trattare i fenomeni che non possono essere descritti appieno con equazioni semplici e comprensibili, l’algebra può diventare mostruosa da applicare e la ricerca di corrispondenze tra diverse soluzioni può diventare incredibilmente difficile. Anche la formulazione della cosiddetta “M-theory”, un colpo di genio nell’unificazione delle diverse versioni della teoria delle stringhe, resta ancora incompleta.
Perché la teoria delle stringhe potrebbe avere successo e le alternative
La teoria delle stringhe è considerata un candidato promettente per una teoria che unifichi gravità e meccanica quantistica perché, in modo naturale, le includerebbe entrambe: uno degli stati fondamentali della stringa corrisponde infatti al gravitone, la particella ipotetica che trasporta l’interazione gravitazionale, che se esiste, ad oggi ha eluso tutti gli sforzi di trovarla dei fisici. Inoltre, la presenza di dimensioni extr nella teoriaa offrirebbe un quadro teorico in cui incasellare la relazione tra le varie forze e leparticelle fondamentali. Ancora più sorprendente è che la teoria offre una descrizione del moto delle particelle attraverso equazioni che discendono direttamente dai principi della teoria stessa. Tuttavia, la teoria delle stringhe non è l’unica strada verso l’unificazione ed è anzi piagata da molte critiche e tecnicissime difficoltà teoriche, nonché dall’assenza di riscontri sperimentali solidi. Tra le alternative si trovano anzitutto la gravità quantistica a loop, che cerca di descrivere lo spazio-tempo curvo come costituito da strutture quantizzate, e approcci più recenti come la teoria degli insiemi causali che vede lo spazio come atomizzato e descritto dall’ordine degli eventi, o la teoria dei sistemi di fermioni causali basata sul tentativo di far emergere lo spazio-tempo da strutture quantistiche più fondamentali, o ancora la teoria dei twistor che ha cercato di sfruttare avanzati strumenti di geometria differenziale ed algebra per dedurre le caratteristiche dello spazio-tempo.
Questi percorsi, pur diversi sì sono contaminati a vicenda, e condividono lo stesso obiettivo: costruire un quadro coerente che descriva l’universo a tutte le scale, dal cosmo alle particelle elementari.
Sapevate che…
Con questa teoria le dimensioni possono essere 11 o più?
Secondo una variante della teoria delle stringhe l’universo potrebbe avere fino a 11 dimensioni, molte delle quali invisibili ai nostri sensi.
Uno dei padri della teoria delle stringhe è italiano?
Il fisico italiano Gabriele Veneziano è considerato uno dei pionieri della teoria delle stringhe, originatasi dai suoi tentativi di descrivere le forze nucleari.
Ci potrebbero essere oggetti chiamati (pronunciando in inglese) “brane”?
Uno dei modi per gestire le dimensioni extra delle stringhe prevede l’esistenza di oggetti chiamati “brane”, che possono ospitare stringhe, andare a spasso per l’universo come fossero particelle, e che hanno contribuito a chiarificare delle dualità nella teoria originariamente inattese.