Nodi difficili da slegare, gli scienziati hanno scoperto che sono più semplici del previsto: smentita una convinzione lunga 90 anni
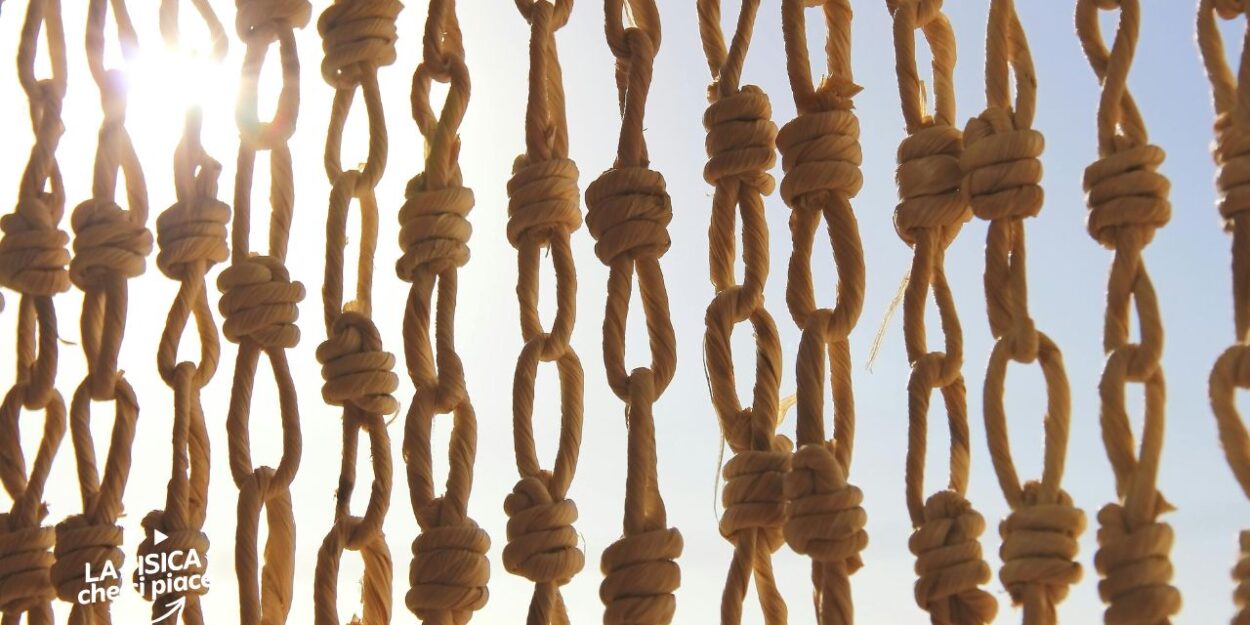
La scoperta è di quelle che lasciano realmente a bocca aperta. Apparentemente arduo da raggiungere, risolvibile in modo molto più agevole del previsto.
Il concetto di nodi può assumere significati diametralmente differenti in base all’ambito in cui ci troviamo a disquisire a riguardo. Di base, si tratta di un intreccio di un elemento lungo, indispensabile per fissare o legare due elementi.
Se attenzioniamo il medesimo concetto in ambito matematico e geometrico, la topologia vede come descrizione principale dei nodi “una curva chiusa nello spazio” con possibilità, anche in questo caso, di intreccio o di annodamento.
Parlando di informatica, invece, con questo termine si indicano punti di connessione all’interno di una rete, necessari al ricevimento, all’elaborazione e alla finale trasmissione dei dati.
Ancora, in ambito scientifico lo studio dei nodi è indispensabile nella comprensione approfondita di strutture estremamente complesse, in termini chimici, oppure relativamente alla biologia umana: un esempio su tutti, il DNA.
Un risultato insperato
E’ il perfetto esempio rappresentato dai grovigli di corde o cavi, dinnanzi ai quali anche i soggetti con la più spiccata manualità incorrono in problemi. Non a caso, anche i più esperti matematici hanno da sempre inquadrato come principio regolante tali situazioni “più grande è il nodo, più difficile è il compito”. E se tutto ciò non fosse perfettamente reale? La ricerca di due studiosi provenienti dall’Università del Nebraska-Lincoln, Mark Brittenham e Susan Hermiller, infatti, è stata in grado di fornire all’attenzione della comunità intera infiniti esempi di nodi composti che paiono decisamente più semplici da districare rispetto ai ben più grandi incroci. E’ importante, prima di tutto, evidenziare una netta distinzione tra i nodi dell’ordinarietà quotidiana e quelli matematici, termine che fa riferimento esclusivamente a quelli che non possiedono estremità libera.
La caratterizzazione dei nodi passa anche dal numero di scioglimento, ossia l’ammontare totale di volte in cui un nodo dovrebbe essere tirato su se stessi per far sì che lo stesso arrivi a districarsi in via definitiva. Quanto ne consegue è che, più passaggi saranno necessari per scioglierlo, più il nodo risulterà complesso. La convenzione fino ad ora valida indicava come dopo l’unione di due nodi, tagliandone ciascuno in un determinato punto e procedendo ad unire le estremità libere, il numero di scioglimento del nuovo nodo realizzato risultasse almeno pari alla somma dei numeri di scioglimento riguardanti, invece, i due nodi individuali, secondo quanto espresso, pensate, per la prima volta quasi 90 anni fa.
Una certezza definitivamente smontata
Era il 1937 ed oggi, con tutta probabilità, possiamo affermare che questa convenzione fosse totalmente falsa. Perché possiamo dirlo con così tanta convinzione? Grazie ai risultati prodotti dal lavoro di Brittenham e Hermiller, che aiutandosi con computer sono riusciti a trovare ulteriori nodi composti, caratterizzati da un numero di disannodatura inferiore alla somma dei numeri di disannodatura dei due nodi individuali.
Il lavoro dei due ricercatori si è fondato sulla volontà di ricercare un controesempio, ma senza aspettarsi di trovarne alcuno, dando per scontato che la convenzione precedentemente vigente fosse pienamente probabile, ma la sorpresa ottenuta nel risultato, se possibile, ha elevato questa scoperta ad un’importanza radicale. A riportarlo è il portale d’informazione tedesco Spektrum.
