La legge di gravitazione universale di Newton rappresenta una pietra miliare nella comprensione delle forze che governano l’Universo. Cerchiamo quindi di approfondire.
Legge di gravitazione universale: tra formule e applicazioni quotidiane
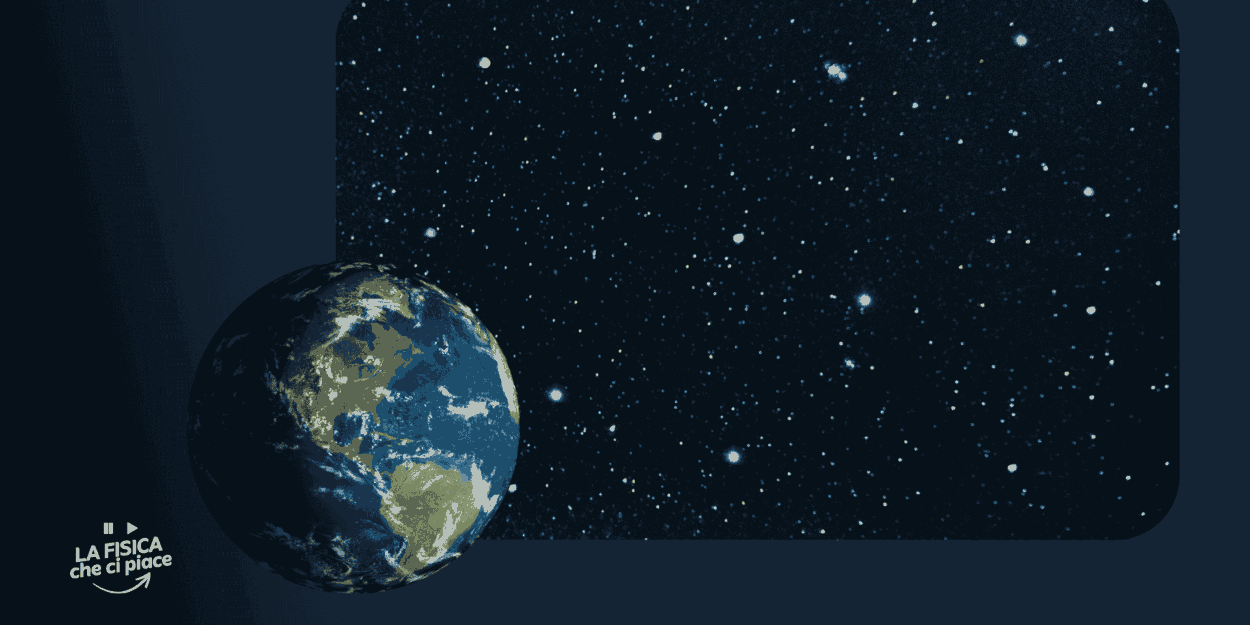
Teorie gravitazionali prima di Newton
Prima di Newton, l’idea di un’attrazione universale tra i corpi era lontana dalla conoscenza del mondo fisico. Per Aristotele la gravità era un moto verso il centro della Terra dovuto alle qualità degli elementi di un corpo, e non esisteva alcuna forza a distanza, bensì un principio di moto verso un “luogo naturale” che spiegava perché gli oggetti pesanti cadono verso il centro della Terra. Ogni cosa per muoversi necessitava di una causa. Il cielo, perfetto, aveva leggi diverse ed era capace di imprimersi da solo il moto.
Nel Medioevo, la teoria dell’impetus di Jean Buridan introdusse il concetto di “impeto”, una sorta di “impulso” trasferito da un corpo all’altro, che manteneva in moto un corpo anche in assenza di contatto o altre cause, gettando così le basi per comprendere il moto dei corpi terrestri, in contrasto con la perfezione del moto circolare uniforme dei corpi celesti. Con Galileo Galilei nacque l’analisi quantitativa del moto propria della meccanica, sorta dello studio della caduta dei gravi. Grazie a queste ricerche, allo studio sull’isocronismo del pendolo che aiutò un calcolo sempre più preciso di tempi, al perfezionamento del cannocchiale, le spiegazioni metafisiche del movimento vennero progressivamente abbandonate. Contemporaneamente le leggi empiriche formulate da Keplero descrissero con precisione le orbite ellittiche dei pianeti, ma rimasero prive di un fondamento meccanico fino all’intervento rivoluzionario di Newton.
La legge di gravitazione universale
La legge di gravitazione universale di Newton afferma che la forza F con cui due masse m1 e m2 si attraggono è proporzionale al prodotto delle masse e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza, è sempre attrattiva e diretta lungo la retta che congiunge i due corpi:
F= G m1 m2 /r2
- F: intensità della forza gravitazionale, misurata in newton [N];
- G: costante di gravitazione universale (6,674×10⁻¹¹ m³·kg⁻¹·s⁻²), introduce per la prima volta un coefficiente quantitativo che rende misurabile l’attrazione tra corpi lontani. Questo piccolo numero venne però misurato in laboratorio solo più di cent’anni dopo la sua introduzione;
- m1, m2: masse dei due corpi, misurate in chilogrammi (kg). L’idea che la massa fosse la sorgente della forza gravitazionale rappresentò un’innovazione rispetto alle teorie precedenti, soprattutto per la sua precisa formulazione matematica;
- r2: distanza tra i centri di massa dei corpi elevata al quadrato, al denominatore per esprimere il principio dell’inverso del quadrato, già intuito da Huygens e Hooke ma formulato in modo definitivo da Newton.
La formula della legge di gravitazione universale incorporò per la prima volta quantità fisiche che erano misurabili tanto per un oggetto in un laboratorio quanto per un pianeta, abbattendo il tradizionale confine fra cielo e Terra.
L’universalità della legge di Newton
Newton definì la sua legge “universale” perché si applica indistintamente a oggetti sulla superficie terrestre, alla Luna, i pianeti e alle stelle lontane, senza distinzione di ruolo o scala. Prima di lui, esistevano leggi “speciali”: la legge di caduta libera per i corpi vicini alla superficie terrestre, le tre leggi di Keplero valide solo per i pianeti intorno al Sole, nonché le regole empiriche per i moti all’interno del sistema solare. Ciascuna di queste si limitava a un ambito particolare, mentre la legge di Newton introdusse un’unica formulazione in grado di descrivere ogni interazione gravitazionale. Poco più di cent’anni dopo la sua formulazione un altro scienziato, Cavendish, riuscì a misurare l’interazione gravitazionale tra due grosse sfere di piombo in un laboratorio, riuscendo su piccola scala a riprodurre quella che è l’attrazione tra due pianeti, compiendo così la misura della costante di gravitazione universale. Sul piano filosofico, la legge di di Newton rappresentò una sintesi rivoluzionaria: una forza invisibile e istantanea che legava ogni corpo dell’Universo all’altro. Tale carattere globale pose le basi per il concetto moderno di campo gravitazionale e il proseguimento delle indagini sulla natura dello spazio e del tempo.
Il contributo della relatività alla gravitazione universale
La teoria della relatività generale di Einstein reinterpretò la gravità come una forza legata alla curvatura dello spaziotempo generata dalla massa e dall’energia. Dalle equazioni di campo di Einstein è possibile ricavare la legge di Newton come un’approssimazione valida in campi deboli e a velocità contenute. La relatività generale spiegò in più la velocità della precessione del perielio di Mercurio, la deflessione della luce ai bordi del Sole e previde le onde gravitazionali, fenomeni non giustificabili con il modello newtoniano. In questo modo la gravità assunse una dimensione geometrica, che ancora oggi non smette di sorprendere.
Applicazioni contemporanee della legge
Oggi la legge di gravitazione universale è importante per la meccanica orbitale dei satelliti artificiali: fornisce una misura approssimata ma rapida del posizionamento dei satelliti geostazionari ed arricchita dalla relatività aiuta la navigazione GPS.
Nello studio delle dinamiche galattiche e planetarie consente di stimare la massa dei corpi celesti.
Nel campo della geofisica si utilizza per calcolare variazioni del campo gravitazionale terrestre legate a movimenti di masse all’interno della Terra. Grazie a strumentazioni moderne come i gravimetri, è possibile misurare variazioni gravitazionali estremamente piccole, utili per l’esplorazione geologica.
Nei razzi e nelle missioni spaziali, il calcolo delle traiettorie è possibile grazie alla conoscenza approfondita delle leggi gravitazionali.
Sapevate che…
La legge di gravitazione permise di scoprire Nettuno?
Gli astronomi notarono delle anomalie nell’orbita di Urano. Usando la legge di gravitazione, ipotizzarono la presenza di un altro pianeta che ne disturbava il movimento. Così Nettuno fu “scoperto” prima ancora di osservarlo con il telescopio!
Newton aveva ragione sulla gravità… ma ne ebbe subito conferma?
Newton inizialmente trovò una discrepanza nel moto della Luna dovuta a misure sbagliate della dimensione della Terra e della sua distanza dalla Luna, ma ben sei anni dopo, con dati corretti, confermò la validità della sua legge gravitazionale.
a cura di Gianfranco Longo