Nel mondo microscopico, governato dalla meccanica quantistica, esiste una costante fondamentale che regola ogni scambio di energia: la costante di Planck. In questo articolo, scopriamo insieme che cos’è, perché è così importante in fisica e come ha rivoluzionato la definizione del chilogrammo.
Costante di Planck: il mattone fondamentale della realtà quantistica
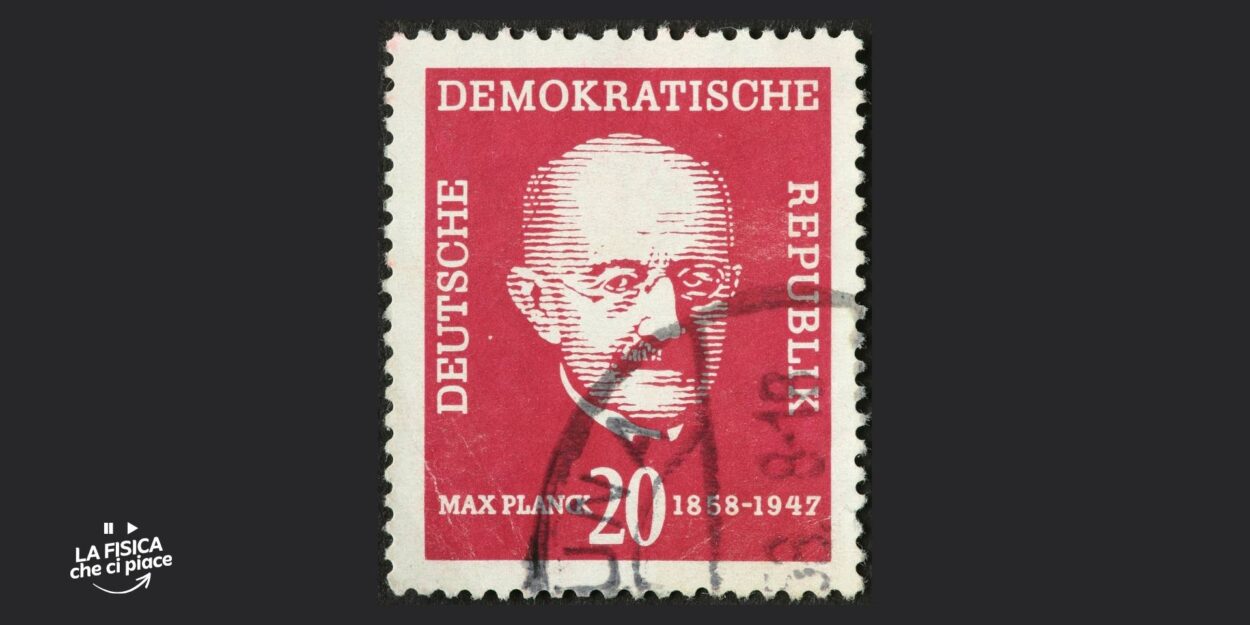
Che cos’è la costante di Planck
La costante di Planck, indicata con la lettera h minuscola, è una costante fisica fondamentale che assume un ruolo chiave nella meccanica quantistica, comparendo in numerose equazioni, come la celebre legge di Planck o l’equazione di Schrödinger.
Il suo valore è pari a 6,62607015 joule per secondo e, avendo le dimensioni di un’energia moltiplicata per un tempo, spesso è anche nota come quanto d’azione.
Con la sua introduzione, agli inizi del ‘900, ha segnato una svolta concettuale profonda, che ha ben presto permesso agli studiosi di comprendere una delle principali caratteristiche del mondo microscopico: la quantizzazione.
All’interno della materia, infatti, si nasconde un mondo sorprendente composto da miliardi e miliardi di particelle, che sfugge completamente ai nostri sensi, inevitabilmente legati all’esperienza quotidiana. Un mondo in cui le leggi della fisica classica non valgono più: qui entra in gioco la meccanica quantistica, una teoria tanto sorprendente da stupire gli stessi scienziati che l’hanno sviluppata. Al suo interno, quantità fisiche come l’energia non possono essere scambiate in modo “continuo”, ma attraverso pacchetti che prendono il nome di “quanti”, ciascuno dei quali è proporzionale alla costante di Planck.
Ma come si è arrivati ad un’idea così rivoluzionaria? Per comprenderlo, dobbiamo fare un passo indietro, agli inizi del Novecento, quando un fisico tedesco di nome Max Planck cercava di risolvere un mistero che la fisica classica non era ancora riuscita a spiegare.
Il ruolo nella meccanica quantistica
All’interno della storia della fisica è davvero raro poter individuare con precisione una data di inizio per lo sviluppo di nuova teoria. Tuttavia, questo non è il caso della meccanica quantistica: tutto ebbe inizio il 14 dicembre 1900, quando il fisico tedesco Max Planck presentò ai colleghi della Società Tedesca di Fisica un articolo che avrebbe rivoluzionato per sempre la visione del microcosmo.
A fine Ottocento, infatti, i fisici si confrontavano con un enigma ancora irrisolto: la radiazione del corpo nero. Le leggi classiche conosciute fino ad allora non riuscivano a descrivere correttamente l’emissione di radiazione elettromagnetica da parte di un corpo nero, ossia di un oggetto che assorbe completamente tutta la radiazione che lo colpisce, senza rifletterne o disperderne neanche una minima parte.
Per risolvere la questione, Planck propose quello che egli considerava un “assunto puramente formale”: ipotizzò che l’energia non venisse emessa in maniera continua, ma in pacchetti discreti, proporzionali alla frequenza della radiazione, introducendo così la costante h come fattore di proporzionalità. Grazie all’introduzione di questa ipotesi, per la prima volta i dati sperimentali combaciavano con quelli teorici.
Tuttavia, per molti anni, Planck rimase convinto che la sua ipotesi rappresentasse un solo espediente matematico e non un fenomeno reale. Eppure, la sua intuizione si rivelò tanto geniale quanto fondamentale: aprì la strada allo sviluppo della meccanica quantistica, ispirando studi successivi, come l’interpretazione dell’effetto fotoelettrico da parte di Einstein nel 1905.
Relazione tra costante ed energia dei fotoni
Uno dei primi e più noti utilizzi della costante di Planck si trova proprio nell’interpretazione dell’effetto fotoelettrico, fenomeno fisico che Einstein spiegò nel 1905, riprendendo l’ipotesi dei quanti introdotta da Planck.
Quando la luce colpisce un metallo, può liberare elettroni dalla sua superficie. Tuttavia, ciò avviene solo se la frequenza della luce supera una certa soglia: un’onda più intensa ma a frequenza bassa non produce alcun effetto.
Einstein spiegò questo comportamento ipotizzando che la luce fosse composta da particelle, a cui diede il nome di fotoni, ciascuno dei quali avente un’energia pari al prodotto della costante di Planck per la frequenza della radiazione. Questa equazione mette in relazione la costante di Planck con l’energia dei fotoni e oggi rappresenta uno dei punti cardine della fisica moderna.
La costante di Planck nella definizione del chilogrammo
A partire dal 2019, la costante di Planck è diventata la base per la definizione ufficiale del chilogrammo, segnando una vera e propria rivoluzione nella storia della metrologia.
Fino ad allora, infatti, l’unità di misura della massa era definita da un oggetto fisico: il prototipo internazionale del chilogrammo era un cilindro di platino (90%) e iridio (10%) conservato sotto una tripla campana di vetro presso l’Ufficio Internazionale dei pesi e delle misure a Sèvres, in Francia.
Sebbene fosse custodito con estrema cura, i limiti di un riferimento materiale, inevitabilmente soggetto a deterioramento e a variazioni impercettibili nel tempo, hanno spinto la comunità scientifica verso una definizione basata su costanti fisiche universali, come già avvenuto per il metro, ridefinito nel 1983 a partire dalla velocità della luce nel vuoto.
Nel caso della massa, si è scelto come riferimento quello della costante di Planck, che è stata elevata a costante nota senza incertezza, al fine di derivare implicitamente una nuova definizione del chilogrammo campione.
Poiché nelle dimensioni di h compaiono sia lunghezze che tempi, il nuovo standard di massa dipende sia dalla definizione di metro che di secondo, dato anch’esso in termini di uno standard naturale. In questo modo, il chilogrammo è oggi definito a partire da due grandezze della natura: la costante di Planck e la velocità della luce.
Nella pratica quotidiana, nulla cambia: un chilogrammo ha lo stesso valore di prima. Tuttavia, per la metrologia di alta precisione, questa scelta rappresenta un grande passo avanti, perché elimina ogni rischio legato all’usura o alla perdita del campione fisico, garantendo stabilità e universalità alla misura della massa.
Sapevate che…
È vero che il valore della costante di Planck è stato deciso per “alzata di mano”?
Nel 2019, il valore della costante di Planck è stato fissato esattamente a 6,62607015 × 10⁻³⁴ J·s, nell’ambito della ridefinizione del Sistema Internazionale di unità di misura (SI). Questa decisione è stata presa durante una conferenza ufficiale del BIPM a Versailles, approvata con un voto a maggioranza dai rappresentanti internazionali, proprio come avviene in un’assemblea.
Quindi sì, è stato deciso “per alzata di mano”, ma sulla base di decenni di misure sperimentali estremamente precise. Questo ha permesso di legare il chilogrammo e altre unità fondamentali a costanti universali della natura, anziché a oggetti fisici.
Esiste anche una costante di Planck “ridotta”?
Sì, esiste una costante di Planck ridotta, indicata con ℏ (che si leggge come “h tagliato”) e definita come ℏ = h / 2π. Viene usata spesso nelle equazioni della meccanica quantistica, come l’equazione di Schrödinger.
Max Planck capì subito quanto fosse rivoluzionaria la sua scoperta?
In realtà, no. Planck introdusse la quantizzazione dell’energia come un “assunto puramente formale”, convinto che non rappresentasse un fenomeno reale. Solo anni dopo, grazie ad Einstein, Bohr e altri fisici, si comprese la vera portata di quella costante e nacque la meccanica quantistica.
a cura di Giada Cacciapaglia