Lo studio dei pianeti che orbitano attorno al Sole ha contribuito a una comprensione approfondita dell’universo e della struttura dei corpi celesti. Cerchiamo di capire cosa sono, come stati chiamati e la loro origine.
Cosa fa di un corpo celeste un pianeta del Sistema Solare?
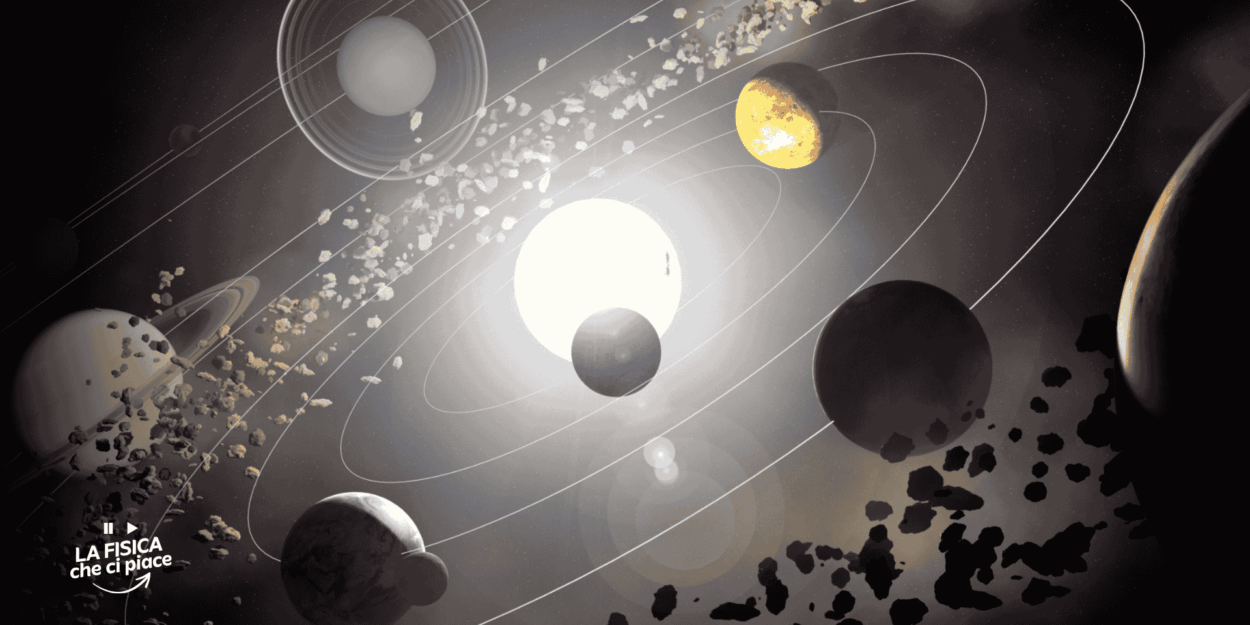
Come si definisce un pianeta?
Nel 2006, dopo millenni di nozioni comuni e vaghe di cosa fosse un pianeta, l’Unione Astronomica Internazionale (IAU) ne ha promulgato una definizione che stabilisce che un corpo celeste è considerato pianeta del Sistema Solare se soddisfa tre criteri fondamentali:
- orbita attorno al Sole;
- possiede una massa sufficiente affinché la sua stessa gravità lo renda approssimativamente sferico;
- abbia “ripulito” la traiettoria orbitale da altri detriti e corpi minori.
Questa definizione ha fornito coerenza nelle classificazioni astronomiche, ed ha portato ad una diversa categorizzazione di alcuni corpi, in particolare quella di Plutone che è stato riclassificato come pianeta nano.
Il criterio della “ripulitura” dell’orbita è particolarmente rilevante nell’identificazione di un pianeta. Ad un certo punto della sua formazione, un pianeta deve essere in grado di dominare la propria regione orbitale, ovvero la sua massa deve essere tale da attirare o espellere altri oggetti di dimensioni comparabili. I corpi che non soddisfano questo criterio, pur possedendo una forma sferica, vengono classificati come pianeti nani. Questi possono persino arrivare a condividere parte della loro traiettoria con la zona di influenza di altri pianeti, detriti o asteroidi.
Plutone, ad esempio, pur evidenziando una forma quasi sferica, non ha eliminato gli oggetti della regione della fascia di Kuiper in cui si trova (un fascia di gas, detriti ed asteroidi che sta oltre Nettuno), ed in più la sua orbita attraversa in parte l’interno di quella di Nettuno. Queste caratteristiche hanno portato l’IAU a classificarlo come pianeta nano.
Terrestri e giganti
Le caratteristiche fisiche dei pianeti variano notevolmente tra loro, rendendo utile una differenziazione tra pianeti terrestri e pianeti giganti. I pianeti terrestri (Mercurio, Venere, Terra e Marte) possiedono superfici rocciose e una composizione prevalentemente silicea e/o metallica, mentre i pianeti giganti, (Giove, Saturno, Urano e Nettuno) sono caratterizzati da una struttura molto diversa che anzitutto non prevede l’esistenza di una superficie distinta dall’atmosfera. Si dividono in due categorie: i giganti gassosi ed i giganti ghiacciati.
I pianeti giganti gassosi, rappresentati da Giove e Saturno, contengono in grandissima parte idrogeno ed elio. La loro massa elevata, la presenza di ampie atmosfere e le elevate pressioni, fanno sì che al loro interno la materia condensi ed assuma proprietà inusuali per la terra, come gas che diventano liquidi a temperature a cui non lo sarebbero, o che incominciano a condurre elettricità come dei metalli. Invece, Urano e Nettuno vengono classificati come pianeti giganti ghiacciati ovvero, sebbene contengano idrogeno ed elio ne hanno molto meno dei giganti gassosi, e comunque nessuna superficie solida. Sono presenti invece elementi più pensanti come azoto o ossigeno, e sostanze come metano ed ammoniaca, che alle temperature di Urano e Nettuno possiamo immaginare “ghiacciati”, da cui il nome.
I nomi dei corpi che girano intorno al Sole
I nomi dei pianeti sono perlopiù ispirati alla mitologia classica, ed in Europa lo sono a quella romana, greca ed affini. Tali nomi sono il risultato della tradizione che ha associato ad ogni pianeta una figura divina, simboleggiando caratteri che in retrospettiva hanno trovato riscontro nelle osservazioni astronomiche. Ad esempio:
- Mercurio: il nome deriva dal dio romano Mercurio, messaggero degli dèi, noto per la rapidità, e non sorprende che questo pianeta abbia il periodo di rivoluzione più breve;
- Venere: prende il nome dalla dea dell’amore e della bellezza, parole che si sposano bene con aggettivi come ardente ed abbagliante, attributi simbolicamente riscontrabili in quello che è il pianeta che appare più luminoso;
- Marte: è denominato così in onore del dio della guerra, riflettendo, in maniera simbolica, la colorazione rossastra “bellicosa” dell’oggetto celeste.
Questi nomi, radicati in uno specifico contesto mitologico, sono stati adottati in molte lingue derivate dal latino e persino nelle lingue germaniche e slave.
Parallelamente alle tradizioni europee, altre culture hanno sviluppato proprie denominazioni per i pianeti in base a simboli, fenomeni naturali o divinità locali. Nella tradizione cinese e giapponese, ad esempio, i nomi dei pianeti si fondano sui cinque elementi tradizionali, la cui scelta sembrerebbe anche qui legata alle osservazioni fatte ad occhio nudo. In cinese:
- Mercurio è chiamato 水星 (Shuǐxīng), che significa “stella d’acqua”.
- Venere è scritto come 金星 (Jīnxīng), traducibile in “stella d’oro”.
- Marte viene denominato 火星 (Huǒxīng), ovvero “stella di fuoco”.
In giapponese si utilizzano logogrammi analoghi, con gli stessi significati, adattati in pronuncia:
- Mercurio è 水星 (Suisei);
- Venere è scritto金星 (Kinsei);
- Marte è 火星 (Kasei).
Nella tradizione indiana, in particolare in lingua hindi, i nomi dei pianeti riflettono il pantheon vedico ed utilizzano termini che indicano divinità e credenze astrologiche. Ad esempio:
- Mercurio è identificato con बुध (Budh), divinità positiva che rappresenta l’energia associata al pensiero e all’intelligenza;
- Venere è legato a शुक्र (Shukra), nome che punta alla dea ed all’idea della bellezza e della prosperità;
- Marte viene indicato come मंगल (Mangala), richiamando il fiero dio dalla pelle rossa, simbolo di forza e coraggio.
Le orbite dei pianeti del Sistema Solare
In ordine di distanza crescente dal Sole, i pianeti sono: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. La loro posizione è indice delle differenze nel modo di formazione e dell’influenza del Sole.
Tutti i corpi celesti del Sistema Solare seguono traiettorie determinate dall’influenza gravitazionale che il Sole esercita su di essi. I pianeti non fanno eccezione, e la forma delle loro orbite è descritta in primo luogo dalla prima legge di Keplero, che stabilisce che i pianeti si muovono lungo orbite ellittiche, con il Sole posto in uno dei due fuochi. Quanto ellittica sia un orbita è misurato dall’eccentricità, che in termini semplici è quanto la traiettoria si discosta da una perfetta circonferenza. In alcuni casi l’orbita è quasi perfettamente circolare, come nel caso di Nettuno o ancor più di Venere, quest’ultimo al momento il pianeta con l’orbita meno eccentrica.
Succede inoltre che l’intera orbita di un pianeta venga nel tempo a spostarsi a causa delle complesse interazioni tra i pianeti, i satelliti e il Sole.
Le velocità con cui i pianeti percorrono le rispettive orbite non è costante: si osserva che quando un pianeta si avvicina al Sole la sua velocità aumenta, e raggiunge il massimo nel punto più vicino (il perielio); mentre la velocità diminuisce quando si allontana dal Sole, ed è minima quando raggiunge il punto più lontano (l’afelio). Questi risultati erano già noti a Keplero che li sintetizzò in quella nota come seconda legge di Keplero.
Ad oggi l’analisi delle orbite non solo costituisce l’oggetto di una interessante analisi scientifica, ma riveste anche un ruolo essenziale nella pianificazione delle missioni spaziali
Origine e formazione del Sistema Solare
Tra i modelli attualmente più accreditati, l’ipotesi della nebulosa solare fornisce la spiegazione più dettagliata per l’origine e la formazione del Sistema Solare. Secondo questo modello, circa 4,6 miliardi di anni fa, una nube interstellare fatta principalmente di molecole di idrogeno, un po’ di elio e polveri ha subito un collasso gravitazionale. Questo processo ha portato alla formazione di un disco protoplanetario in rotazione, ovvero una regione all’interno della quale si sono concentrati i materiali che avrebbero dato origine al Sole e agli altri corpi celesti orbitanti.
Si suppone che ci siano state una serie di fasi ben distinte. In un primo momento, il collasso gravitazionale ha portato alla formazione del proto-Sole, al centro del quale si accentrava la maggior parte della massa del Sistema Solare, benché in questa fase il Sole non si fosse ancora acceso. Intorno a questa proto-stella, il resto del disco protoplanetario ha iniziato a coalescere formando aggregati sempre più grandi. Nei territori interni del disco, dove le temperature erano più elevate ed erano presenti materiali che potevano essere solidi a quelle condizioni, si sono formati i pianeti terrestri attraverso gli urti e la coesione dei detriti rocciosi. Questa meccanismo ha portato alla formazione di corpi con composizione prevalentemente silicea e metallica. È possibile che molti altri corpi rocciosi si siano formati oltre agli odierni, ma probabilmente sono stati smembrati da altri pianeti o espulsi dal Sistema Solare.
Parallelamente, nelle regioni esterne del disco, a distanze abbastanza grandi da avere temperature sufficientemente basse da far solidificare sostanze come acqua e metano, si andavano formando i pianeti giganti. Le teorie attuali suggeriscono che i pianeti giganti si siano formati inizialmente intorno ad un nucleo “solido” (composto da materiali ghiacciati e rocciosi) che successivamente è riuscito a catturare grandi quantità di gas dal disco circostante. Giove in particolare rappresenta il pianeta più massiccio del Sistema Solare: in pratica è una sorta di proto-stella che non ha trovato abbastanza gas per riuscire a crescere. Inoltre, la formazione dei giganti gassosi potrebbe essere avvenuta su orbite diverse da quelle attuali, e solo in seguito sarebbero migrati in quelle correnti.
Quando finalmente il Sole si accese, un ulteriore elemento chiave nel processo di formazione entrò in gioco: il vento solare. Gli intensi flussi di particelle cariche hanno contribuito a rimuovere il gas residuo dal disco protoplanetario, interrompendo l’accrescimento dei pianeti terrestri e limitando la quantità di materiale disponibile nelle regioni interne. Il vento solare ha avuto un ruolo decisivo anche nel modellare la composizione atmosferica dei pianeti.
Quel che rimane del disco protoplanetario sono la fasce degli asteroidi tra Marte e Giove, e la fascia di Kuiper che si estende oltre Nettuno.
Nonostante le molte ricerche fatte ci sono ancora molti dubbi su come il Sistema Solare si sia formato, ed alcune delle sue zone sono difficilmente visibili ed ancora poco esplorate.
Sapevate che…
Saturno è più leggero dell’acqua?
La densità media di Saturno è inferiore a quella dell’acqua: circa 0.687 g/cm³, contro 1 g/cm³ dell’acqua
Il sole è constantemente attraversato da onde?
Il Sole è costantemente percorso da oscillazioni dovute ad onde di pressione che lo attraversano. Queste oscillazioni forniscono informazioni sulla struttura del Sole e sono studiate in una branca dell’astrofisica chiamata eliosismologia.
Venere è una specie di Terra rovente?
Anche se sono simili per dimensioni e composizione, Venere è posto terribile dove abitare: la sua temperatura superficiale arriva a 470 °C, abbastanza da fondere il piombo, e la sua atmosfera ha una pressione elevatissima ed è fatta per la maggior parte di anidride carbonica, acida per la presenza di anidride solforosa e con un effetto serra micidiale che lo mantiene rovente.
a cura di Gianfranco Longo